
Anfore spogliediDomenico La Rocca |
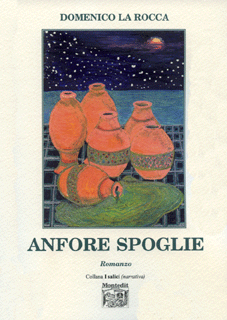
Collana "I Salici" - I libri di Narrativa
15x21 - pp. 242 - Euro 14,50
ISBN 978-88-6587-1171
Clicca qui per acquistare questo libro
In copertina Anfore Spoglie, da un dipinto dello scrittore
Premessa
Nella ritemprante quiete dei patii del paese di Montevago si svolge la naturale quotidianità scandita dall’attesa dei meticolosi segnali degli astri, in un continuo incessante evolversi di eventi e contraddizioni ponderati da sentimenti di familiarità e amistade.
Come le silenti anfore, dritte e imperterrite sui palmenti al chiuso, e le poderose giare, ferme e attente sui larghi spazi dei cortili, preludono ai segni celesti, gli aedi raccontano arcane storie tramandate oralmente dai cantori del tempo, un susseguirsi di accadimenti che segnano, al di là del bene e del male, la vita dell’uomo sulla Terra. Piccole comunità si muovono in una logica fattività d’un microcosmo cresciuto e sviluppatosi a misura e passo d’uomo, il lavoro nei campi, nelle botteghe artigiane, in una convivenza semplice e aggregante, lontana da stressanti metropoli e macrocosmi che annullano l’individualità dell’essere umano avviluppandola in una poltiglia omogeneizzata, massificata e uniformante che disgrega subdolamente qualsiasi tessuto sociale, riducendolo a mera materialità consumistica.
L’inesorabile fluire del tempo innesca ogni giorno la spola veloce e lesto dipana trame e orditi in un intricato avvicendarsi di amori e segreti, invidie e gelosie, passioni e amicizie, tradimenti e ambizioni meschine. Ma senza alcun preavviso, come un’infausta visitazione superna, ebbre potenze annientanti e devastatrici in pochi secondi stroncano alla radice la compostezza di una vita misurata e fattiva, inducendo l’uomo a barcollare inebetito, tra la vita e la morte, sugli alti precipizi dell’ultimo confine su cui andrà ad espiare le sue futili irriducibili velleità e le proprie imponderabili vane superbie.
Anfore spoglie
Ai miei genitori
PRIMA PARTE
I.
Le antiche acque del fiume Belice, dalle propaggini del monte Pelevel agli arcani alvei dell’Hypsas e del Crìmiso, in dolci suoni accarezzano i ciottoli ricoperti dal muschio smeraldo, emanando lieti gorgoglii sui greti stesi tra olezzi e afrori inebrianti. Paciose greggi pascolano sui pendii cespugliosi, rimpinguandosi le viscere sui pacifici silenzi interrotti dai fischi sibilanti dei pastori che spaccano le onde degli echi vaganti sulle colline intorno. Alle giovenche tintinnano i campanacci alle giogaie mentre brucano le fragranti sulle, stese a macchie sui declivi verdeggianti.
Al di là delle sponde del fiume s’innalza maestosa a spalti la grande parete di pietra arenaria del Sajaro: fronde sempreverdi coprono un misterioso e gigantesco anfiteatro naturale che s’indora da zenith a nadir.
E la vita s’affaccia alle soglie del paese di Montevago e segue il suo corso nella fattiva laboriosità dei suoi abitanti, una civiltà contadina millenaria che si tramanda gli insegnamenti dei Padri impartiti nelle antiche contrade in cui la vita si forgia con la sua naturale logicità di esistervi, uomini e donne al servizio di loro stessi, con i loro miti e le loro fiabe, gli armenti e le greggi, le loro regole da rispettare e che tutti si obbligano a rispettare.
Nel bel mezzo delle morbide ondulazioni collinari colorate di gialli fluenti e verdi cangianti, affiorano sinuosi alberi d’ulivi centenari, ballerine sul piedistallo che danzano alle carezze dei venti nel paradisiaco afrore dei rosmarini e degli oleandri in fiore. Fra gli orti rigati dalle zappe sciamano le api e le farfalle svolazzano sui cardi irti. Silenti mulattiere bianche serpeggiano nelle campagne in gran numero e in tale ordine che si possono all’apparenza scambiare per le aiuole di un gran semenzaio.
Le violette ai cigli delle viuzze si aprono al vento che sibila tra i fitti canneti, mentre schiere d’uccelli rapaci roteano e stridono sopra poderosi alberi di fichi.
L’azzurro del cielo e l’invisibile carezza dei venti si dissolvono in un solo unico elemento e tutto appare disteso sul giardino della Valle del Belice, tra le siepi e il verde fogliame degli aranci e dei limoni carichi di frutti.
E l’aria spande deliziosamente i profumi esotici delle erbe e delle tenere essenze nella più assoluta naturalità.
Le vie di Montevago a prima vista possono apparire deserte, a volte lo sono anche, ma si contrappongono ai grandi cortili interni in cui si svolge la vita di tutti i giorni. Androni profondi preludono a giardini con piccole fontane addobbate d’antica maiolica.
Sul poggio a ridosso d’una vasta piazzola, nei pressi d’una cava estrattiva, un uomo attendeva. Il viso serio, gli zigomi appena visibili sulle guance piene, gli occhi castani e severi. Una folata di vento caldo gli arrivò in faccia, mandandogli i capelli per aria. Se li ravviò prontamente. Carezzò il viso rasato da poco e il profumo del dopobarba si mescé agli aromi della campagna circostante.
Nell’attesa, trasse la pipa dalla tasca, già carica di tabacco, accendendola al riparo del cavo della mano. Aspirò del fumo e la bocca gli s’impregnò d’acre aroma. Alla camicia e ai pantaloni sahara di cotone leggero non rinunciava mai e, già dalle prime giornate estive, li indossava ben volentieri. Guardò l’orologio, aggrottando le sopracciglia. Dalla pipa partì una boccata di fumo, rimanendo soprappensiero per il ritardo del lavoro dei fuochisti. Si voltò imperturbabile in direzione dell’ingresso della cava.
Tutto appariva immobile, il silenzio aleggiava surreale sulle vaste ondulazioni collinari che si perdono a vista d’occhio, quando, dal sommesso brusio selvaggio delle radure, un’improvvisa esplosione lanciò in aria schegge di pietra aggrovigliate in un rutilante barlume proiettato verso il cielo.
Il verde delle colline tagliava come un filo d’acciaio l’aria sospesa tra lo spazio cosmico e i precipizi orlati di saracchi e radici gonfie verso l’aria pulverulenta.
Immoti massi di pietra baluginavano sotto un sole raggiante che già dalle otto di mattina, sul barometro dell’ufficio, segnava una temperatura di 20 gradi.
Cessata l’onda d’urto della volata, l’uomo scese per uno stretto sentiero, s’immise su erti gradini e si diresse verso la piazzola degli uffici.
Una torretta si alzava di un piano sull’alloggio dei custodi.
Sulla costruzione in muratura e cemento, un cartello con la scritta indicava: direzione.
Ignazio La Rocca entrò nel disimpegno, prima di varcare la soglia della sala direzione. Un attaccapanni in legno, sul lato sinistro della porta, sorreggeva una giacca.
Grandi stampe di congegni meccanici pendevano dalla parete di fronte alla scrivania in legno con due sedie davanti. Accanto allo schedario con le tessere degli operai, un grande tavolo reclinabile su cui stendere disegni e mappe planimetriche.
Sopra mensole impolverate, un vecchio trattato di arte mineraria primeggiava su altri libri e registri di misure e contabilità. Papiri e schizzi di disegno erano rimasti srotolati da più d’una settimana e lasciati lì per un’eventuale revisione. Ignazio prese i fogli sistemati sulla scrivania e diede una rapida occhiata.
Come due mastodontiche valve di conchiglia, la cava appariva un’immane voragine spinta a spirale sino al fondo di uno spalto centrale. Al primo passo carraio un segnale di pericolo richiamava lo sguardo dei passanti: attenzione! pericolo!
Il secondo passo carraio veniva posto in uso per non intralciarsi gli automezzi in entrata e in uscita con i mezzi circolanti all’interno cava. A pochi metri di distanza a chiare lettere una scritta: cave estrattive.
Lungo le pareti della roccia echeggiava l’assordante frastuono dei motocompressori che spingevano aria compressa ai martelli pneumatici.
Un brulicante sfolgorio di mezzi in movimento proiettavano schegge di luce nell’aria. Sui crinali della cava, disseminati qua e là, tramogge e macchinari.
La cava a cielo aperto col passare degli anni assunse l’aspetto d’un polifemico anfiteatro e la massa rocciosa pian piano si era ricomposta in gradoni.
Le rocce venivano abbattute per fronti verticali con l’ausilio di mine in fornelli, collaborate da mine più piccole ai piedi del fronte, a carica eseguita con esplosivi progressivi. Un improvviso colpo di vento innescò una spirale di polvere e spinse mulinelli verso il cielo. Un autocarro si affiancò alla macchina caricatrice in retromarcia per effettuare il carico. Un bulldozer avanzava simile ad un gladiatore meccanico, ruggendo sui cingoli a ruote dentate e brandendo l’indistruttibile dozer, la possente lama per dissodare terreni e rimuovere qualsiasi cosa si trovasse sul suo percorso. Sul retro il ripper, l’aratro per svellere pietre e radici.
Al mattino presto le strade rimangono velate di rugiada, sino all’arrivo del sole. Prima che le tenebre si dissolvessero con le stelle, il gallo aveva già cantato tre volte. Al battere d’un picchiotto, i cardini d’una porta dirugginirono. Sull’uscio una donna, ancora in vestaglia, indugiò, protese la testa e guardò a destra e a manca. Rese un pallido sorriso al lattaio nel porgergli il contenitore, come ogni mattina. Scambiarono due parole e l’uomo si affrettò a versare il latte fresco appena munto. Altre porte seguirono nella via, sacro rituale di tutte le mattine.
Nella bottega dei fabbri la fornace era già pronta. Dopo i soffi e i cigolii del mantice azionato dalle forzute braccia di Gino, Menico vi pose il ferro a scaldare e, divenuto rovente, lo serrarono fra due lunghe pinze per stenderlo sull’incudine. E i due picchiavano forte, picchiavano ancora, alternandosi con la precisa cadenza d’un orologio svizzero sul massello che bruciava di porpora infernale, facendo quello che volevano, sino a domarlo e renderlo il più malleabile possibile.
I colpi vibrati echeggiavano per tutta la via; con le pinze i fabbri tormentavano il ferro sull’incudine in tutta la sua circonferenza: lo voltavano e lo giravano, lo allentavano e lo riafferravano e ogni volta lo raggiungevano, lo abbattevano, lo schiacciavano, vibrandovi sopra energici colpi di martello.
Il ferro irradiava girandole di faville, colpo su colpo, cambiando colore, sino ad appiattirsi. Immerso con rapidità nell’acqua fredda, si spegneva, acquistando uno spessore uniforme. Anche gli Dei ebbero un fabbro e, senza la fucina di Vulcano, Giove non avrebbe avuto i suoi fulmini: i due fabbri magari non avevano cognizione della loro origine divina, canticchiando in mezzo al turbinio delle faville, ma può darsi che le scintille che sprigionava di volta in volta la saldatrice avrà fatto loro pensare a qualcosa di magico e soprannaturale.
Nel cortile di zia Cristina, di fronte alla bottega dei fabbri, stamattina alcune donne entravano e uscivano dalla stanza attigua alla cucina.
Ieri pomeriggio, dietro la porta a vetri che dà al vialetto del pozzo, una donna s’affaticava a forza di braccia sopra un enorme impasto di farina: lo manipolava, prendendolo a pugni, lo arrotolava, lo srotolava, lo stritolava tra le mani, versandogli sopra dell’acqua calda.
Dal comignolo una colonna di fumo segnalava che qualcuno avesse attizzato il fuoco per scaldare il forno. Grossi pani bianchi, per bastare una settimana, stavano disposti sul tavolo di faggio, in attesa della lievitata sotto il calore delle coperte di lana.
Di fronte al portone del cortile, con sibili, fischiettii e ammiccamenti, gli artigiani si richiamavano fra di loro, lasciandosi andare a battute e doppi sensi:
«A la ’zza Cristina ci fuma ’u cufilaru…» – A zia Cristina fuma il comignolo – azzardavano in coro sulla soglia delle botteghe lungo la via.
E la battuta in men che non si dica passò di bocca in bocca per tutto il quartiere, annunciando che da un momento all’altro la zia Cristina li avrebbe invitati ad assaggiare il pane appena sfornato, tagliato a metà e cospargendo la mollica fumante di olio, origano, un pizzico di sale e, per chi ne avesse avuto voglia, su un piattino avrebbe trovato stuzzicanti sarde salate.
Lungo il viale a ridosso d’una fattoria, Luigi Falesi, aedo montevaghese conoscitore di storie e racconti tramandati dai suoi antenati, passeggiava ai piedi dei grandi eucalipti dalle foglie luccicanti in un luminoso meriggio di fine giugno.
Meditava, meditava parecchio su reminiscenze che serbava nella sua ferrea memoria e le rimuginava volentieri con quel suo spirito antico per tenersele vive nel cuore come gliele avevano narrate i suoi maestri.
Gli occhi cerulei, perspicaci e profondi, nascosti da pesanti palpebre, seguivano i dossi erbosi oltre i quali il vecchio ha immaginato sempre scorgervi ancora quelle antiche città perdute nell’inesplicabile oblio del tempo.
Ma la sua memoria non tradiva, gli insegnamenti impartitigli dagli antichi aedi rimarranno indelebili segni sacri nei suoi pensieri più reconditi. Dal panciotto estrasse la cipolla e, sbirciandola con un ghigno che indusse la sua folta barba bianca ad inarcarsi, mirò le lancette:
«Già, quando mio figlio dà un appuntamento, non rispetta mai gli orari, che sbruffone.» bofonchiò sommessamente, ridacchiando a denti stretti.
Arricciò il naso e dondolò la testa, contemplando oltre l’immensa vegetazione che si stagliava alla sua vista. Inspirò l’aria fresca e gli olezzi invitanti delle macchie aggrovigliate sui cigli immoti del viale. Portò la mano destra alla fronte per schermarsi dai raggi obliqui di ponente e catturò gli scorci aperti tra imponenti alberi sul limitare del bosco. Come apparivano lontani i tempi della sua giovinezza, il ricordo dei genitori, i periodi bui della prima grande guerra quando una terribile, inenarrabile carestia si abbatté su tutto il territorio ed ogni giorno che passava non si riusciva a intravedere una via di uscita.
Il padre con i suoi figli accompagnavano gli armenti ai pascoli e con i proventi dei frutti delle mandrie non patirono mai la fame, ma constatarono le difficoltà che tante famiglie del paese dovettero patire.
Luigi conobbe ragazzi del suo tempo che sentivano d’essere fortunati soltanto a possedere una fetta di pane in una mano e nell’altra una fetta di mollica per companatico. Che tempi!
Intere serate al buio con il tenue alone d’una candela, nei lunghi inverni, attorno al braciere nella stanza grande e tutti i presenti raccontarsi storie e ricordi, esperienze di vita e a volte anche i sogni.
I bambini rimanevano a bocca aperta ad ascoltare le favole dei narratori e seguivano passo passo le parole e i gesti di chi le sapeva raccontare, ma arrivava il momento di precipitare fra le braccia di Morfeo.
Uno sgretolio sulla ghiaia indusse il vecchio a girarsi. Dal varco sulla via apparve il figlio Andrea su cui baluginarono violentemente le luci dell’ultimo sole.
Alla vista del suo vegliardo, già cominciava ad allargare le braccia come per scusarsi del ritardo.
«Papà, papà, come mi dispiace! T’ho fatto attendere, e parecchio.» disse il figlio, annaspando tra il fogliame che costeggiava il viottolo. L’attesa s’era certamente protratta, ma sapeva che il vecchio filosofo aveva un buon rapporto con il tempo e il suo imperterrito fluire.
«E che t’è partorita la cavalla, Andrè?!» gli esternò con palese sarcasmo l’aedo e proseguì: «Con te ormai ci ho fatto il callo, figlio mio. So bene che ti fai attendere, e come!» disse, ghignando e scuotendo la testa.
«Papà, perdonami, ma ho dovuto salutare degli amici che si trovavano a passare da queste parti e mi sembrava brutto non attendere che partissero. E così ci siamo intrattenuti per un bel po’ al Caffè Italia. Poi, lo sai benissimo che lo zio Saverio con i clienti ha quel suo modo affabile e gentile, ed una parola tira l’altra…» cercò di giustificarsi Andrea, avvicinandosi a braccia aperte.
«Hai fatto bene, non preoccuparti. L’ospite è sacro dalle nostre parti.» confermò il vecchio, battendogli le mani sulle braccia, prima di stringerselo al petto.
In lontananza un abbaiare di cani ruppe il brusio invitante che aleggiava sui declivi.
«Due passi li ho già fatti, Andrè, ma non credere che non ne abbia più voglia. Anzi, proseguiamo, perché mi pare che stai diventando pigro, in questi ultimi tempi.» continuò l’aedo, fissandolo negli occhi con quello sguardo indagatore che non lasciava scampo a chi gli si trovava davanti.
«Ma che dici, papà, con gli amici di buon passo ne calchiamo viali di campagna e tratturi.»
E s’incamminarono per una ventina di metri prima di inoltrarsi per un sentiero ai cui bordi folti cespugli di more e mirtilli ne adornavano il percorso sino alle sorgive d’acqua perenne.
A tratti, antichi muri a secco affioravano dai grovigli di macchia mediterranea abbarbicati ai banchi di tout venant. Padre e figlio giunsero alla fontana e non persero tempo ad avvicinarsi alla sorgiva d’acqua, approntarono il cavo delle mani e la sorseggiarono, prima di sedersi sul sedile intagliato nella pietra, davanti al quale un incantevole paesaggio di lenti dossi e ampie doline si perdeva sino a lambire le fauci del mare.
E da qui, il vecchio amava contemplare la vastità del Mediterraneo che sembrava assumesse lo stesso colore del cielo e apparirgli una sola cortina avvolta in coloriture d’intenso turchino che lasciava con il fiato sospeso.
«Allora, Andrea, qualche giorno fa, mi avevi accennato di una persona, un ricercatore di cui non ricordavi il nome, ma poi non ne parlammo più, non avemmo occasione di riprendere la discussione.» disse il vecchio, portandosi la mano alla barba e lisciandosela.
«Beh, quando te l’accennai, rimasi sul vago perché volli prima conoscere meglio don Francesco, il nuovo padre conventuale, che mi aveva chiesto notizie sulla storia antica di Montevago, di quello che accadde su questa zona in tempi lontanissimi. Che vuoi, conosco la storia ortodossa, ma non ho voluto sobbarcarmi in una materia di cui non riesco a trarre più di tanto dalle ultime ricerche, dato che ho intuito che lui ricerca notizie proprio speculari. Così ho pensato a te.» chiarì Andrea, umettandosi le labbra.
«Ah, don Francesco! Sì, sì, ho capito di chi parli, il nuovo superiore del convento. Ne ho sentito parlare…una persona a modo pare che sia, … speriamo che non cozzi con il nostro caro parroco.» esclamò l’aedo, traendo un lungo sospiro e pizzicando due foglioline di menta che annusò con beatitudine.
Il vecchio si soffermò meditabondo a contemplare uno stormo di volatili provenienti dal mare. Poi riprese:
«Beh, così su due piedi non è tanto facile discuterne. E poi bisognerà pur far mente locale, seguire una certa logica, magari se mi collabori cercheremo di puntualizzare i vari periodi che si sono susseguiti sul nostro promontorio.» disquisì il vecchio con voce ferma e decisa.
«È chiaro. Allora vedrò di temporeggiare sino a che sarai deciso ad incontrarlo e che sia lui stesso a parlartene.» osservò Andrea, intuendo che l’argomento si sarebbe comunque profilato abbastanza complesso e non lo si poteva buttar lì in quattro e quattr’otto.
Tutto il pomeriggio l’ingegner Vittorio Dalmes, con i gomiti poggiati sul suo inseparabile tavolo da disegno color verde acqua marina, dopo aver tracciato linee e svolazzi sui vari papiri sparsi in giro per lo studio, si accingeva a redigere quel progetto che da tempo gli balenava nella mente e al quale non avrebbe facilmente rinunciato: crearsi un piccolo giardino sulla propria abitazione.
Il pennino scorreva dritto sulla riga, la sua mano sicura e meticolosa per naturale attitudine, sempre attento alle sbavature. E sul papiro stava per prendere forma la sua idea chiara e inequivocabile. Si levò dalla sedia girevole e accese una sigaretta; spalancò la porta e indugiò sulla soglia, cogitabondo e fiero. Lanciò lo sguardo al tramonto che indugiava sulle auree radure dell’antica Selinunte. Dalle campagne imbrunite si ergevano intense colonne di fumo. Fresco aleggiava già per le vie del paese. Passi di viandanti echeggiavano a fianco dei lunghi muri delle case.
All’angolo di via Crispi si delineò l’inconfondibile sagoma del geometra Paolo Gelsi che si cimentava in gesti e dondolamenti del corpo in un’accesa discussione col fratello. Sembrava dovesse proseguire sino a notte fonda, ma presto si salutarono per seguire direzioni opposte.
«Allora, come va?» gli domandò il geometra, con i capelli all’aria e tutto accaldato.
«Da dove spunti fuori, così elegante? Sembri un figurino che deve andarsi a fidanzare subito subito. Ti manca solo l’anello e un mazzo di fiori.» esordì il collega, sogghignando sull’uscio dello studio.
«Te l’avevo detto che oggi presenziavo al matrimonio di mio cugino Pippo che ha sposato Francesca, la figlia di Michele.» disse Paolo, annuendo e roteando le mani all’insinuante battuta rifilatagli per ribadire la sua ostinata condizione di giovane scapolo.
«Oh, è vero, hai ragione, me n’ero scordato.»
Vittorio prese per un braccio Paolo e lo invitò al tavolo da disegno:
«Che vedi di nuovo? Guarda cosa ho schizzato.»
Un fischio di meraviglia e di approvazione partì dalla bocca del geometra nel vedere quel meticoloso disegno redatto dal suo collega durante la sua assenza:
«Ma hai superato te stesso, benissimo. Stai realizzando il tuo sogno, caro ingegnere.» esclamò Gelsi.
«Beh, va prendendo corpo, ti pare? Il problema che più mi assilla è quello dei pesi sul tetto. Ma questo dilemma cercheremo di risolverlo.» proferì l’ingegnere, stringendo la bocca ed osservando il disegno.
«Credo che il solaio sopporterà bene il peso delle piante, considerato il quantitativo che ne hai stabilito, non vedo quale problema potrà esserci.» soggiunse il geometra, battendo le dita sulla pergamena.
Vittorio rifletté, strofinandosi la barba ispida di tre giorni, poi disse:
«Alla stesura primaria del progetto decisi, a suo tempo, che il carico maggiore avvenisse sui pilastri centrali dell’intera costruzione, anche se allora non predisponemmo pilastri agli angoli della casa.»
Gelsi indugiò qualche attimo, prese una matita e la picchiettò sul tavolo, osservando:
«È una struttura mista, ma è pur vero che i muri laterali sono portanti e abbastanza solidi da poter reggere un bel po’ di peso, e poi, tirando le somme, le piante che dislocherai sul terrazzo non credo raggiungano un tale peso da incidere in maniera determinante sulla tolleranza elastica dei solai!»
L’ingegnere accese il sigaro e tra una boccata e l’altra si strofinò le labbra con il pollice, e poi pensieroso si rivolse al collega:
«Al limite, sai cosa possiamo provare?»
«Cosa? Se hai qualche soluzione…»
«Con dei pesi sul tetto e il flessimetro potremmo verificare l’oscillazione di tolleranza del solaio.»
«Ottima idea! Meglio non correre rischi.»
Il pomeriggio del sabato i due discussero parecchio per riuscire a mettere insieme idee avanguardiste e profuse reminiscenze di romanticismo, passando alternativamente dalle teorie più evolute allo scherzarci un po’ su.
Al calar della sera, sciogliendosi il sole al di là delle colline che si stagliano imperituri a ponente, i lampioni di corso Umberto tracciavano lunghe prospettive di luci proiettate a ventagli sulla strada che dal parco della Rimembranza seguivano sino alla statua di Garibaldi. Sommessi brusii s’alzavano dalle siepi costrette ai bordi dei viottoli.
Gli alberi come grandi pennelli sfioravano il cielo serotino. Due uomini passeggiavano nel parco, sui vialetti acciottolati, fermandosi e riprendendo, gesticolando con parsimonia, seguendo le diverse tonalità musicali che gravavano sulle parole rimaste ad aleggiare eteree nell’aria mite che volgeva diafana e serena alla notte misteriosa.
Al Caffè Italia un bambino indugiò col gelato in mano sulla soglia, avvolto dalla luce delle lampade multicolori, in attesa che il padre si sbrigasse al bancone. Le luci intermittenti della vetrina richiamavano gli occhi dei passanti. Elitre di falene vibravano attorno ai barlumi dei lampioni.
Striduli alterchi di tanto in tanto scoppiavano fra donne nei cortili, mentre le comari si affaccendavano una dietro l’altra per evitare che si giungesse alle mani. Impassibili i due capponi appesi a testa in giù prima che venisse loro tirato il collo e spennati nell’acqua bollente.
Ragazzini del quartiere si rincorrevano alle prime ombre della sera, dopo essersi lanciati in puntate esplorative per le vie e le viuzze per decidere dove acquartierarsi e insieme giocare, a salta montone se erano in tanti, oppure a nascondino, fino a quando, raggiunti dai loro genitori, venivano trascinati a casa per i capelli o tirati per un orecchio, ma qualche sodo scappellotto vibrava sonoro sotto gli occhi degli altri ragazzi che pian piano se la davano a gambe.
[continua]


