
IncontridiFrancesco Gambellini |
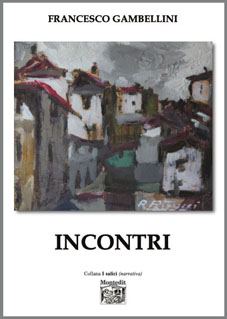
Collana "I Salici" - I libri di Narrativa
15x21 - pp. 132 - Euro 11,50
ISBN 9791259512420
Clicca qui per acquistare questo libro
In copertina: dipinto di Remo Petrucci di proprietà dell’autore
Quel giorno…
Mi ricordo a un tratto di quel giorno come fosse ieri.
Calzavo zoccoli di legno rumorosi e scomodi, come molti altri ragazzi nel primo dopoguerra; e mio padre che lavorava in farmacia aveva saputo di un tale che aveva un paio di scarpe di pelle e cuoio vero da vendere, e aveva preso appuntamento per l’indomani alle nove, e per le nove meno cinque io dovevo essere lì.
Fummo tutti puntuali, e un signore, mostrando le scarpe in questione “Quanti anni hai?” Mi domandò.
“Dodici.” Risposi senza capire.
“Proprio come Marco. Ti dovrebbero andar bene. Il poveretto non ha fatto in tempo manco a guardarle, falciato da una raffica di mitraglia di un aereo improvviso.
Le scarpe di un morto!
“Non mi vanno.” Dissi deciso.
“Ma se non l’hai manco misurate!” Si meravigliò mio padre.
Allora infilai un piede nella tomaia, ma aggricciai i diti in modo che il piede non potesse andare in alcun modo né avanti né indietro.
“In effetti sono un po’ strette.” Fu costretto a riconoscere, deluso, il venditore.
Ed io me ne tornai ai miei zoccoli di legno che battevano secchi sul selciato, ma con una voce allegra, quasi ringraziando.
Incontri
PROLOGO
Io non ho mai avuto altro da darvi che parole. Ve ne ho lasciate quante ho potuto in tutto quello che ho scritto in modo che non possiate dimenticarle.
“Per farne che? – Mi domandi sconcertato – Posso forse comprarci quel terreno che confina col mio e che da sempre mi piace?”
“Non puoi, certo.”
Eppure la parola è potenza, credimi. Al punto che se discutendo, il tuo avversario ha mille ragioni e tu soltanto una parola in più, alla fine sarai tu a prevalere.
Diceva Don Lorenzo Milani “Ogni parola che non conosci oggi è un calcio in culo che riceverai domani.” E il calcio in culo è il modo colorito di dare un nome alla sconfitta. Io sono ricco soltanto di parole, e di quelle soltanto sarà l’eredità che vi lascio. Non guardate alle case e ai terreni, se ci saranno. Io penso che l’unica cosa che ci dirà Dio, se c’è, e soprattutto se avrà un po’ di tempo per noi, “Io ti ho dato una parola in più… Che ne hai fatto?”
Già, che ne ho fatto?
Scopro la mia pochezza dalla difficoltà che trovo nel dissotterrare in qualche modo una risposta.
Eppure la troverò.
La troveremo, se verrai con me.
“Venire con te? E dove?”
“Pensaci bene: tutto quello che noi diciamo o scriviamo non è parto esclusivo del nostro cervello. L’abbiamo semplicemente raccolto per le strade percorse da quando siamo in vita, o lo abbiamo rubato a quanti, andando, abbiamo incontrati.
Dove andare dunque, vuoi sapere?
Ma a cercare le strade che un tempo camminammo e che, magari, sono cadute dalla nostra memoria.
È lì la nostra identità segreta.
GUERRA
Se vogliamo conoscerci un poco dobbiamo scambiarci le nostre esperienze che certamente dissimili, ci hanno fatto così come siamo.
Io, per esempio, perché tu mi conosca a fondo, sento il bisogno di raccontarti la guerra che io ho patito personalmente, mentre tu, più fortunato, l’hai solo sentita raccontare come una favola. Ecco perché, se non ti parlo della mia guerra, tu non puoi capire le cicatrici dolorose e profonde che essa mi ha lasciato. Eccola dunque:
MILANO, AGOSTO 1943
Invano cerchi tra la polvere,
povera mano, la città è morta.
È morta: s’è udito l’ultimo rombo
sul cuore del Naviglio. E l’usignolo
è caduto dall’antenna, alta sul convento,
dove cantava prima del tramonto.
Non scavate pozzi nei cortili:
i vivi non hanno più sete.
Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:
lasciateli nella terra delle loro case:
la città è morta, è morta.
Salvatore Quasimodo
“Ma oggi è giovedì, Professore!” Protesti tu.
“E allora?”
“Allora non è il giorno della poesia, ma quello da te riservato ad una delle tue storie.”
“Che racconta appunto di questo:
bq. …e l’usignolo
è caduto dall’antenna, alta sul convento,
dove cantava prima del tramonto.
Quale nefandezza più atroce di questa?
E questa è la guerra.
E proprio della guerra io voglio raccontarvi.”
Avevo otto-nove anni quando caddero le prime bombe sul mio paese.
E il giorno dopo ancora.
E ancora.
Da alcuni si ipotizzò una spia che informava gli americani sui movimenti dei tedeschi e su come colpirli.
Altri invece erano certi che la disgrazia del mio paese era di trovarsi su una via di comunicazione piuttosto importante per chi volesse spostarsi con una certa rapidità.
Io avevo solo paura.
Per evitare guai seri quella mattina ci spostammo su un colle di fronte dove un conoscente ci offrì ospitalità in un suo casale dicendosi più tranquillo in compagnia di gente conosciuta e sicura.
Eravamo quasi sereni, e, godendoci quel bel sole, gustavamo pane bruscato con un filo d’olio a condimento.
All’ora solita, però, eccoti ancora in avvicinamento la minaccia dei soliti bombardieri.
Corremmo a rintanarci nel casale, e mio padre, continuando senza accorgersi a mangiare, tirò per prudenza il catenaccio.
Ma ci avevano visto fuggire.
Ce lo dissero tirandoci giù una bomba che cadde a una decina di metri da noi.
Vedemmo il catenaccio piegarsi, fatto molle e flessibile.
E più ci atterrì la scarica di mitraglia contro di noi.
Era chiaro che dovevamo fuggire.
“Fuggire dove? – Piangevo io − Ci raggiungerebbero dovunque. Anche gli animali lo sanno, e sono spariti.
Nasconderci semmai!”
Ma il pianto e le ragioni d’un ragazzino non hanno alcun peso in certi momenti.
E poi tutti s’erano già dispersi per prepararsi ad andarsene; ed io non potevo far altro che seguirli.
Mio padre però disse che prima dovevamo recarci in farmacia dove, come m’aveva avvertito, il signore delle scarpe sarebbe arrivato.
Non era semplice, in quei tempi difficili, come da accordi presi in precedenza, avere la fortuna di trovare un buon paio di scarpe, magari a prezzo scontato.
Era un’occasione da non lasciarsi scappare.
“Ma perché proprio in farmacia?” Domandai.
“Prima di tutto perché la farmacia è sempre aperta, − mi risposero − e poi perché il mio babbo aveva fatto la guerra, assegnato, come altri, a fiancheggiare un gruppo di medici, troppo pochi per il molto da fare.
Era stato lì che aveva imparato a disinfettare ferite e a bendarle a dovere; a distribuire medicinali appropriati, buoni a lenire i dolori e a rispedire al fronte quei poveretti che magari ti ritornavano indietro con una gamba da amputare.
“Ma almeno tu, − li consolava in qualche modo, − lasci questa guerra di merda e te ne torni a casa tra gente che ti vuol bene.”
Insomma aveva imparato il mestiere, tanto che al suo rimpatrio per un malanno improvviso, fu assunto come pratico nella farmacia locale; e lì ci attendeva il signore delle scarpe.
Per incontrarlo dovemmo tornare in paese.
Non so bene perché l’avevamo dovuto lasciare, ma i grandi, sempre piuttosto informati, dicevano che gli americani erano oramai sicuri della presenza, nelle case requisite, del grosso delle truppe tedesche, e stavano preparando un bombardamento a tappeto che non avrebbe lasciato in piedi pietra su pietra.
Fuggire quindi.
Quello che ricordo di quel buio terribile non è soltanto il gelo solito d’una notte d’inverno, ma un gelo misto a paura, simbiosi terribile pronta a far di noi individui tremanti e schizzati, forse mai partoriti prima da un essere umano o ferino.
Come già detto, per incontrare il signore delle scarpe dovemmo tornare in paese.
Lo rivedevo con malcelata curiosità, dopo i bombardamenti che l’avevano profondamente violato.
Negozi per lo più chiusi e gente senza sorriso che tirava via dalle case tutto quanto poteva.
La chiesa era spalancata e io v’entrai; e c’era lì Don Mario che brancolando qua e là tra i vetri colorati in frantumi sparsi in terra e la madonna della navata laterale andata in pezzi, piangeva come non l’avevo mai visto.
Mio padre era commosso e la sua emozione coinvolgeva anche me; allora lo tirai via dicendogli che volevo vedere la parte più danneggiata dalle bombe.
C’erano due o tre che frugavano ancora tra le macerie alla ricerca vana di qualcosa di utile da scavar fuori.
Io badavo ad altro: le bombe avevano scoperto buchi segreti e pertugi adatti per giocare a nascondino.
“Qualche altra bomba e sarebbe perfetto.” Pensai.
Ma io ero appunto un ragazzino ottonovenne.
In farmacia c’era già il signore delle scarpe che, vistici arrivare, si diede a magnificarle dicendo che il poveretto non aveva fatto in tempo manco a misurarsele falciato dai colpi di mitraglia di un aereo di passaggio.
Le scarpe di un morto!
“Non mi stanno bene.” Decisi subito.
“Ma se non l’hai ancora misurate!” Mi rimproverò il mio babbo porgendomi un calzatoio.
Allora io infilai sì il piede nella scarpa, ma aggrinzai i diti in tal modo che nessun calzascarpe potesse spingerlo dentro.
“Effettivamente sono un po’ piccole.” Fu costretto a riconoscere il proprietario riprendendosi a malincuore le scarpe del morto.
Una staffilata gelida di vento e un brivido feroce. Ricordo il buio e il freddo di quando fummo costretti a fuggire per cercare uno scampo dalle bombe e trovare un riparo nelle campagne intorno.
Caricammo il solito carro agricolo preso in affitto, di tutto quello che poteva servire per una prima sistemazione in qualche luogo, e il mio babbo prese dalla farmacia quello che gli parve indispensabile per allestire un pronto soccorso sia pure sommario.
Io presi un’armonica che non sapevo suonare, ma ci soffiavo dentro cavandone fuori dei suoni che forse erano musica, e che, se no, mi facevano in qualche modo passare il tempo.
E poi via.
Ricordo l’addio manzoniano di Lucia ai luoghi della sua giovinezza.
“Bello.” Dissi dopo averlo letto. E nient’altro.
Ma ora era l’addio doloroso ai luoghi che m’avevano visto crescere.
Addio strade e piazze del mio paese dove con ragazzi in festa si giocava alla guerra con pallottole di fango indurito che ci esplodevano tra i piedi senza farci male.
Addio verdi colline d’erba che in primavera si riempivano di giunchiglie o di magiche stelle pratoline.
“E non ricordi, − mi dice ancora mio padre, morto tanti e tanti anni fa, − i tristi giorni di novembre quando ancora una volta dovemmo fuggire lontano dal paese nelle campagne intorno?” Prendemmo tutto quello che poteva servirci per una prima sistemazione in qualche luogo, e andammo senza saper dove.
Scoprimmo allora il bello che ci era intorno anche se non l’avevamo mai badato: gente sconosciuta che ci salutava, e che ora, nel momento del pericolo e dei patimenti, voleva condividerli con noi perché ci scoprissimo fratelli e ci sentissimo meno soli.
“Anche nelle situazioni peggiori, a guardar bene, c’è sempre qualcosa di bello da scoprire.” M’aveva detto un giorno il mio babbo.
E il bello era la gente intorno che cercava in tutti i modi d’esserti utile; e chi ti indicava la strada più agevole da fare, chi ti aiutava a spinger fuori il carro da una fossa in cui s’era impantanato.
Questa la scoperta più bella: la gente. Che nei momenti più difficili ti dava una mano per trartene fuori.
“Perché?” Gli domandavi.
“Di questi tempi se non ci aiutiamo tra noi, − rispondevano − chi altro vuoi che lo faccia?”
Andammo così, or qua or là, trovando sempre gente pronta ad offrirci ospitalità e finimmo infine per accettare l’offerta del proprietario della farmacia in cui mio padre lavorava.
Era una grotta molto profonda e comoda in cui fu facile sistemarci.
C’erano pagliericci più morbidi dei letti, e qualche mobile essenziale: un tavolo, sei sedie, un vecchio armadio in cui riporre il cambio dei nostri vestiti.
Ci adattammo assai bene a questa nostra nuova abitazione.
Non ci mancava niente.
Per un po’ di luce nelle ore del buio avevamo una candela, pronti a spegnerla all’arrivo della vedova nera (così chiamavamo l’aereo che di notte veniva puntualmente a ronzare sulle nostre teste finché non aveva sganciato la sua unica bomba, e noi, con un sospiro di sollievo, potevamo finalmente goderci sonni tranquilli).
“Dall’uomo più burbero, più cerbero se vuoi, si può sempre cavar fuori un gesto di tenerezza.” M’aveva ripetuto più volte il mio babbo.
Ed io ne avevo derivato che da quello più lontano, sconosciuto magari, poteva venirci un aiuto inaspettato.
Accanto alla grotta in cui ci eravamo sistemati, c’era uno scavo appena accennato in cui accendevamo un fuoco per un po’ di calore.
“Ma è più il freddo della notte che il calore di quel po’ di brace. − Rise il Ternese, chiamato così forse perché questo era il suo cognome, o più semplicemente perché era originario di Terni, venuto lì a cercare dei medicinali che gli servivano. – Ci vuole almeno un riparo.”
“Ci vorrebbe sì! Servirebbe però il permesso del proprietario per…”
“Ma che permesso! In tempi così difficili, tutto è di tutti. Ci penso io.”
E deciso, senza darci il tempo di replicare, salì nel bosco soprastante, e ne tagliò in un amen sei alberi, dritti come occorrevano.
Poi se ne andò.
“Torno nel pomeriggio con tutto quello che mi serve.” Disse.
Vennero in due; chiodi, martelli, saracchi, pialle e quant’altro.
“Ma come possiamo sdebitarci?” Dicemmo noi confusi da tanta gentilezza.
“Ognuno a suo modo. Noi ti facciamo una capanna per passare il tempo e divertirci, e tu ci offri un bicchier di vino e una purga quando ci serve.”
Risero insieme, e siglarono l’accordo con una stretta di mano.
Parevano del mestiere, tale era la sicurezza con cui si muovevano.
A sera lo scheletro era già in piedi.
“Torniamo domani nel pomeriggio col maggio e la ginestra che ci servono.”
Venne fuori un capolavoro di capanna con perfino, in alto, un foro per l’uscita del fumo.
Anche questo è la guerra: gente che nel momento del bisogno è pronta a darti una mano.
O magari Frustichì che arriva stravolto e col terrore negli occhi a raccontare che un aereo in fiamme gli ha tirato giù una bomba enorme che per fortuna non è esplosa.
“Proprio a qualche metro da me! − Giura strascicando le parole. − Che mi potesse morire mia moglie se non dico la verità.”
“Divorzio all’italiana.” Pensa malignamente qualcuno.
Ma alcuni, pochi, gli credono.
Gigi, ad esempio, un artificiere che incappato in un congegno maligno ci aveva rimesso tre diti della mano destra ed era stato congedato con una medaglia, dice subito: “Andiamo a vedere, non si sa mai.”
Gli basta un’occhiata e l’odore inconfondibile della benzina. “Ma è un contenitore di carburante scaricato da un aereo prima di cadere.”
“Nella zona di Pratalto è caduto, − disse Nicolino sempre informato di tutto − e s’è trasformato in un rogo da cui a stento è stato tratto in salvo il pilota, tanto mal ridotto tuttavia, che s’è giudicato impossibile trasportarlo in qualche modo nel più vicino ospedale senza aggiustarlo almeno un po’.”
Mio padre aveva quel che serviva per una prima medicazione sommaria; e da lui lo portarono.
Prese lo strumento adatto e cominciò a tirar via lembi di pelle bruciati dal fuoco, poi cosparse tutto con una polvere bianca e cominciò a bendarlo.
Non riuscii a reggere e corsi dietro una fratta a vomitare tutto il pranzo consumato da poco.
Quando tornai lì, sentii che tutti stavano discutendo il da farsi.
Alcuni, ed erano i più, pensavano che gli americani, una volta sbarcati in territorio italiano ci sarebbero stati grati se gli avessimo restituito il pilota curato in qualche modo meglio che si poteva.
Ma il mio babbo, fino allora in silenzio, mise tutti a tacere spiegando il suo disaccordo. Si dovevano considerare le condizioni del poveretto: l’occhio destro completamente bruciato e il sinistro compromesso esso pure. Senza contare che probabilmente s’era trattenuto alla guida dell’aereo in fiamme per permettere a tutti di paracadutarsi in salvo, e sicuramente aveva respirato il fuoco.
L’unica cosa da fare era ricoverarlo d’urgenza in ospedale.
Doveva capire un poco l’italiano, perché atterrito farfugliò parole supplicando: “No! Ospedale no! Tedeschi no!”
Cercarono di convincerlo: “Tranquillo. – Gli dicevano − No tedeschi. Ospedale civile italiano.”
Parve calmarsi.
“Italiani… − si fermò cercando la parola − italiani good.” Disse infine soddisfatto e sicuro d’essersi ben spiegato.
Ma Pasquale che si vantava d’aver visto il Belgio e perfino l’Olanda tradusse: “Italiani gustosi, ha detto. Questo ci vuol mangiare.”
“Ma non si regge manco in piedi.” Li tranquillò Giorgino che frequentava medicina all’università di Vattelappésca.
C’era da qualche tempo, nella casa di campagna del proprietario di quelle terre, una morìa di galline che non si spiegava, a meno che non avessero trovato in qualche luogo, libere com’erano di becchettare qua e là, qualche cosa di nocivo tale da ammalarle gravemente fino alla morte.
Una festa per il custode delle pecore che ne faceva spanciate pantagrueliche senza nessun disturbo.
Il padrone però non si fidava, tanto che tirò il collo a una quarantina delle più malandate, vi aggiunse una damigiana d’olio, e diede al suo fattore l’incarico di accompagnare il poveretto in ospedale raccomandando al direttore di curarlo il meglio possibile, senza naturalmente che i tedeschi ne venissero a conoscenza.
Dopo un paio d’ore i tedeschi erano lì.
Caricarono galline e olio, e poi il pilota ferito assicurando che l’avrebbero curato al meglio.
Morì il giorno dopo, non si sa come.
Ma la guerra era anche il gioco del sì e del no.
Quel giorno arrivarono su automezzi blindati e armati come se andassero a far guerra numerosi gruppi di tedeschi che parlarono a lungo col Podestà che continuava a scuotere il capo: “Poi voi ve ne andate e io rimango qui con tutti i problemi.” Trovarono alla fine un accordo: avrebbero essi fatto il nome di tutti gli abitanti della cittadina e il Podestà con un sì o con un no avrebbe indicato quali di essi erano effettivamente i nativi e quali no.
I no furono sètte.
Se li portarono via spiegando loro, per tenerli buoni, di aver bisogno di manodopera che controllasse le vie ferrate mantenendole sempre perfettamente percorribili e che sarebbero stati pagati come tutti gli altri in modo che alla fine dei lavori tornassero tra i loro con un buon gruzzolo.
Al Podestà dissero invece di sospettarli spie, e che li avrebbero fatti lavorare finché non si fossero traditi.
Non sapemmo da nessuno quanti e quando e se lo fecero, ma è certo che non avemmo mai notizia del loro ritorno.
Continuamente, intanto, venivano richiamati uomini sempre più giovani per andare al fronte a sparare al nemico.
Qualche giorno per imparare a premere il grilletto e poi via, per un tozzo di pane appena sufficiente a tenerli in piedi con gli occhi aperti.
Via gli uomini, a sostituirli in patria, (poste, negozi e uffici vari), eran chiamate le donne che oltre a quello del governo della casa s’accollavano ora il lavoro dei tanti uomini mandati a spararsi addosso.
[continua]


