
Il Canonico di San SeverinodiMaria Chiara Firinu |
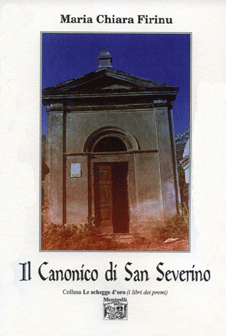
Collana "Le Schegge d'Oro" - I libri dei Premi - Narrativa
14x20,5 - pp. 162 - Euro 13,00
ISBN 978-88-6587-2208
Clicca qui per acquistare questo libro
In copertina e all’interno fotografie dell’autrice
Pubblicazione realizzata con il contributo de IL CLUB degli autori l’autrice è segnalata nel concorso letterario Jacques Prévert 2012
Il Canonico di San Severino” di Maria Chiara Firinu è un amorevole recupero memoriale che alimenta il ricordo fino a renderlo palpabile nelle sue molteplici sfaccettature. L’Autrice accompagna nella rievocazione, con discrezione, muovendosi tra reale ed immaginario, con la sua scrittura avvolgente sempre capace di rendere dominante la forza interiore e, allo stesso modo, la magia del tempo”.
Massimo Barile
(presidente del premio letterario “J. Prévert” sezione narrativa)
Prefazione
“Il Canonico di San Severino”, opera di Maria Chiara Firinu, rappresenta un corposo recupero memoriale che attraversa la vita dell’Autrice, partendo dall’amata “austera e solida casa” dell’infanzia per passare, poi, a continue registrazioni di ricordi che si riferiscono alla sua famiglia; alle varie vicende che si sono susseguite nel tempo, all’osservazione del mondo naturale e della vita agreste, ed infine, alla scoperta della figura del Canonico Adalberto che aveva abitato, molti anni prima, proprio nella loro casa.
Maria Chiara Firinu, pagina dopo pagina, dimostra di padroneggiare completamente il cospicuo bagaglio memoriale e mette in piena luce la sua formidabile capacità di saper raccontare, con esposizione capace di affabulare, sia le vicende personali e familiari oltre alla bellissima storia del Canonico di San Severino, che diventa una sorta di romanzo inserito nel diario esistenziale.
La sua parola è sempre affascinante ed ammaliante, grazie ad una scrittura limpida e fluida, capace di narrare ciò che ha contrassegnato un determinato momento o ha visto lo svolgersi di una vicenda più o meno importante: il passato ed il presente si miscelano come in una caccia al tesoro che è rappresentata dalla storia personale del Canonico Adalberto.
Si assiste ad un lento affioramento di eventi e vicissitudini che hanno fatto parte della sua vita e tornano in superficie anche stati d’animo e percezioni che, sovente, sono nascoste nelle zone più profonde dell’animo.
La memoria corre sul filo, con gli “occhi sognanti”, con la nostalgia e l’amarezza, con il cuore che pulsa di vita autentica: tutto è pervaso da una profonda sensibilità.
Ecco allora dipanarsi la vita intorno all’antica casa di famiglia a San Severino, in compagnia delle otto sorelle. Lei era una bambina timida, molto coscienziosa e aveva una formidabile memoria: quando aveva gli incubi o i sogni ricorrenti che la gettavano nella paura più totale, sapeva che poteva contare sul conforto nella madre che la tranquillizzava con la sua presenza, ma, purtroppo, doveva fare i conti con le incomprensioni del padre, severo e solitario, e che aveva un debole per la sorella maggiore.
La sua vita era a contatto con gli animali, dalla capretta Muntàra all’amato cane Bisagno al piccione Dodò, per non parlare delle inaspettate incursioni dei famelici corvi. Il risvolto della medaglia era che, nelle vicinanze della loro casa, c’era la terra rossa, anzi, il “fango rosso”, che conteneva scorie nocive a causa delle estrazioni dei minerali dal sottosuolo, attività fiorente in varie zone della Sardegna in quel periodo.
In Sardegna lo chiamavano “il male del minerale” e, anche lei, nonostante fosse una bambina di pochi anni, aveva già potuto constatare gli effetti mortali, causati da quelle terre nocive, sugli animali che venivano a contatto, quotidianamente, con quel terreno pericoloso.
Dalla memoria emergono le figure della nonna, donna piccola e magra, praticamente immobile sulle gambe, che “sgranava il rosario tra le dita” e raccontava storie con la sua dolce voce e, poi, la figura commovente di zio Giovanni, uomo timido ed indifeso, che cantava la sua ninna nanna alle bambine, ma che, fin da piccolo, si era ammalato a causa di una forte insolazione ed era stato sempre protetto, per tutta la sua vita, dalla sorella: alcuni ricordi sono struggenti, come quello della sua amicizia con un porcospino che si metteva sotto il lavello della cucina e mangiava solo pane e caffellatte che gli dava il buon zio Giovanni.
Lei era una bambina curiosa e voleva sapere “quando e per quanto tempo” il canonico avesse abitato nella loro casa: la sua immaginazione volava ma, in realtà, di quel canonico non si aveva nessuna notizia. L’inaspettato ritrovamento di un vecchio quaderno, in un cassetto di un antico trumeau, era la possibilità per sapere qualcosa in merito: fortunatamente, si narrava, per filo e per segno, tutta la vita del Canonico Adalberto, fin dalla sua nomina a San Severino.
Ecco allora che si snoda una sorta di romanzo memoriale della sua vita: era sensibile e generoso; dispensava consigli e amava il prossimo; accoglieva i viandanti ed i bisognosi; era capace di fare mille cose, dai lavori manuali come potare gli alberi, al restauro di vecchi mobili, alla rilegatura di antichi testi sacri. Amava la vita e le cose semplici; amava stare con la gente e, nel profondo del suo cuore, serbava un dolore per la lontananza da Rachele, ma aveva seguito la sua vocazione e, poi, dopo qualche tempo, lei si era sposata. Nel corso degli anni, però, aveva sempre mantenuto un fitto carteggio con lei, salvaguardando, fino all’ultimo, l’amore puro che aveva provato per lei.
Ulteriore commovente narrazione che accompagna i ricordi preservati nel tempo affinché non cadano nell’oblio: e Maria Chiara Firinu dimostra di possedere una meravigliosa capacità narrativa, una propensione alla trasposizione letteraria di quotidiani avvenimenti e, ancor più, dell’animo delle persone legate ai propri affetti, di mirabili suggestioni ed incancellabili atmosfere che sono davanti ai nostri occhi ma, purtroppo, sono pochi coloro che riescono a rendere vivo e pulsante tutto ciò. Lei ci riesce nel miglior modo possibile.
Maria Chiara Firinu estrae dallo scrigno della memoria queste numerose “immagini del passato”: gli affetti intensi e profondi, l’amore per le persone care; poi, le vicende esistenziali della propria famiglia e la storia “sconosciuta” del Canonico di San Severino, in una miscela di sommessi ricordi e recuperi memoriali che hanno rappresentato la vita stessa, vissuta ed amata, con tutte le cose belle ma anche con i momenti di sofferenza e dolore.
La vita è meravigliosa e ogni istante… vale una vita.
Massimo Barile
Il Canonico di San Severino
Ai miei genitori
Ai personaggi di queste pagine che mi
hanno aiutato a rievocare.
Ringrazio Edgardo per la collaborazione.
Prima Parte
1. La Memoria
Qualcuno dice che perché i sogni non si ripetano è necessario raccontarli, subito, al risveglio. Se ti dimentichi di farlo o non vuoi, vuol dire che vuoi che si ripetano e se vuoi è perché ti sono piaciuti e vuoi sognare ancora le stesse cose.
Non so se questo consiglio sia una diceria o se abbia un fondamento provato scientificamente. Se è così, ci si riferisce senz’altro al fatto che il parlarne agisca come liberazione.
Io ho deciso di raccontare perché i miei sogni non sono sogni ma incubi e non posso pensare di volerli ripetere per provare, di nuovo, sensazioni spiacevoli anche se vissute solo nel sonno.
Da bambina avevo degli incubi.
A quindici anni avevo gli stessi incubi.
A vent’anni gli incubi continuavano uguali ed adeguati all’età e cominciarono ad avere spiegazioni precise. Avevo paura di perdere mia madre.
Non so se sia la stessa cosa raccontare o scrivere ma, dato che depositare ricordi o incubi su un foglio di carta non nuoce a nessuno, mi accingo a farlo scegliendo un angolo della casa dove ci sia silenzio e solitudine.
Voglio togliere dalla mia mente le cose che mi pesano per lasciare libero ingresso a cose più piacevoli.
La mia mente ha sempre registrato tutto rimandandomi in continuazione anche ricordi che non voglio. Per questo motivo, ora, mi sento una specie di computer che ha bisogno di essere ripulito.
È vero che tutto ciò che è stato fa parte dell’esperienza e della vita. Spero sempre, però, che la vita non mi regali più incubi ma situazioni gradevoli che possa tenere in mente senza essere costretta a “pulire il computer”.
2. L’infanzia
La casa di San Severino era ancora lì: bella, austera e solida.
La sua solidità era rappresentata dai muri di cinta larghi un metro, costruiti con pietre irregolari miste a scisto e tenute insieme da una malta di terra e fanghiglia antica. L’insieme conferiva alla costruzione un senso di sicurezza e di protezione che ognuno di noi ricerca per tutta la vita.
L’intonaco, cadente in alcuni piccoli spazi, aveva ancora un bel colore giallo senape che tendeva allo scuro. È vero che il tempo, su di esso, era passato tante volte e continuava a passarci, ma a dare quel tipo di colorazione contribuivano soprattutto, oltre le pietre di scisto inserite nella costruzione, anche il fango rossiccio delle cave che esistevano intorno.
Il fango rosso che era stato accumulato negli anni aveva costituito ormai delle vere e proprie montagne somiglianti, per struttura estetica, ai canyon del Colorado.
Con quei canyon effettivamente non avevano, oltre quel po’ di somiglianza esteriore, niente in comune perché il materiale che aveva formato quelle strane montagne era nocivo e pericoloso in quanto risultato di scorie di minerali del sottosuolo da cui erano stati estratti la galena ed il piombo.
Circa cento anni prima infatti era sorta una costruzione alta ed estesa, ancora esistente, tirata su con piccoli mattoni rossi ed adibita anche a produzione d’acido solforico e di “bianco di zinco”.
Quando il vento soffiava forte, l’impianto dell’acido solforico non dava certamente il meglio di se stesso e i fumi dell’anidride solforosa, trasportati di qua e di là come mulinelli, andavano a depositarsi oltre che sui muri della grande casa anche nei polmoni dei suoi abitanti. Il vento in questione, per giunta, si abbatteva feroce sia sulle montagne naturali che su quelle di fango e le conseguenze erano molto più gravi per gli abitanti della casa, soprattutto quando non pioveva.
La polvere rossa, spinta dal vento, andava anch’essa a depositarsi, sia nei muri esterni della solida abitazione che negli interstizi delle finestre e della porta principale.
Quando, dopo due o tre giorni, il vento cessava, era necessario ripulire abbondantemente l’interno della casa per evitare che la respirazione, l’ingestione ed il deposito di quella polvere creassero guai alla salute.
La polvere rossa era fastidiosa e pericolosa anche al solo contatto con la pelle. E la famiglia prendeva le giuste precauzioni.
La letteratura sull’argomento, all’epoca, era cosa ridotta; ma si parlava, sia pure in punta di piedi, del fatto che fossero agenti chimici dai quali stare a debita distanza. Studi, ricerche e statistiche successive evidenziarono gravi casi di silicosi polmonare, tumore e, a diversi livelli, alterazioni del sistema vascolare cerebrale.
Tali problemi non avevano, allora, procurato danni alla bella famiglia che abitava la casa.
E in quella gran bella casa, a San Severino, tutti insieme si stava bene.
A parte i giorni di vento, l’ambiente e l’aria che si respiravano erano speciali. E tutto ciò che faceva da contorno alla vita, alberi, animali e minerali, erano libri generosi, sempre aperti per formare ogni giorno “la testa delle bambine”.
Le bambine abitavano in quella casa.
Ed erano tutte bambine.
“Tutte femmine?”, come diceva la gente ogni volta che venivamo presentate o che se ne parlava.
“Sì, tutte femmine”. Il maschietto, infatti, era volato in Cielo lasciando un rimpianto incolmabile per tutta la vita.
Dopo di lui, per tentare di riempire quel gran vuoto, arrivarono in quella casa ancora tre femmine che aggiunte alle altre già esistenti formarono un gruppo di otto sorelle.
Ma bisogna tornare indietro.
Nella casa, la lunga scala d’ardesia scura era rimasta uguale, e il nuovo capofamiglia non aveva voluto sostituire i gradini con materiale più moderno. E, allora, non si era presentato nemmeno il bisogno di una modifica.
Quella scala non era faticosa: aveva una pedata gentile e non era né troppo ripida né troppo inclinata. A differenza di quel che succede abitualmente, era stato indovinato tutto: inclinazione, larghezza, pedata ed estetica. Inoltre, anche se si faceva attenzione per non sporcarla, era di facile manutenzione perché l’acqua che veniva usata per il lavaggio era abbondantemente e velocemente assorbita dall’ardesia che, diventando immediatamente più scura, conferiva al materiale un aspetto elegante e nobile.
Altro pregio non trascurabile di quella scala era “il fresco”. È per questo motivo che le angurie e l’acqua nella brocca di terracotta avevano in quel luogo un deposito abituale.
Bisogna dire che sotto la scala e di lato, a destra, c’era un vuoto che dava in parte nel sotterraneo e in parte nel giardino.
Al vuoto ricavato nel sotterraneo, si accedeva dall’esterno, attraverso una porta che a livello del giardino aveva tre scalini alti e ripidi costruiti proprio sulle fondamenta. Non avevano esattamente l’aspetto tipico della scala ma di sporgenze quadrate nelle quali era appena possibile poggiare i piedi per poter scendere e salire.
Quel sotterraneo era adibito a cantina e ripostiglio per vecchie damigiane e bottiglie dalle fogge strane ma, per via del difficile accesso, visitarlo risultava molto pericoloso. Il ripostiglio, che oltre alle bottiglie ospitava anche un mobile antico, era abitato dai pipistrelli, dai ragni e dalle loro tele.
Le loro tele non erano trasparenti. La continua tessitura operata da quelle bestiole aveva fatto sì che le trame, abitualmente quasi invisibili se di recente fattura, fossero grosse e scure come una tela di iuta sporca di fuliggine.
I ragni erano grassocci e oltre che neri anche pelosi. Le loro dimensioni, fuori dalla norma, facevano pensare, che da anni fossero sempre gli stessi.
Da bambina, visitando per la prima volta quel luogo, pur non avendo paura dei ragni comuni e delle altre piccole creature che avevo l’opportunità di incontrare nella campagna, ebbi paura di quei ragni.
La seconda visita al ripostiglio infatti, a causa di quegli indigeni, fu rimandata di qualche anno.
La bambina che ebbe il coraggio di rientrare lì dentro fu la mia sorella primogenita.
Mia sorella aveva deciso, un pomeriggio d’agosto, di fare assieme a me un’altra visita in quel “bel fresco”.
Lei non era più una bambina ed il suo sbocciare le dava più coraggio di quanto ce ne volesse per fare visita ai ragni.
Mia sorella entrò.
Io stavo ad osservare titubante, pronta a scappare.
C’era troppo buio e troppo odore di muffa per decidere di entrare. Di fatto però non volevo stare indietro a mia sorella che dimostrava più coraggio. Decisi, alla fine dei conti, di non avere coraggio e non entrai. Ricordavo il batticuore di qualche tempo prima e non ero ancora pronta per sopportarne un altro. Decisi quindi di rimandare la visita.
Di lì a poco mia sorella fece un salto e balzò fuori all’improvviso. Una fila di bottiglie, sorrette da una mensola in legno ormai marcio, era caduta dando il via ad un volo di pipistrelli spaesati che, senza criterio e senza meta, volteggiarono nel piccolo umido ambiente.
Ma il battesimo di paura era ormai fatto.
Mia sorella da quel dì entrava ed usciva dal ripostiglio come se fosse il posto più bello del mondo.
Io aspettavo che nascesse in me un po’ di grinta e intanto osservavo le sue imprese.
Era ormai risaputo, che la terra rossa della Contea di San Severino, fosse nociva. I diversi gradi di nocumento erano visibili purtroppo anche nel regno animale e vegetale. Solo a livello umano ancora non era possibile quantificare i danni che, in grande silenzio, andavano ad annidarsi nelle persone che vivevano e lavoravano nella zona.
E più tardi, per fortuna molto più tardi, i guai causati dalla polvere e dall’acido solforico furono ben visibili e purtroppo inarrestabili, per il capostipite della bella famiglia.
3. Gli Animali di San Severino
I problemi per gli animali invece c’erano sempre stati: mali visibili, eloquenti e privi di soluzioni.
Bisogna sapere che nella bella famiglia, con la mia nascita, fu acquistata una vivace capretta alla quale venne dato il nome di Muntàra.
Definirla capretta è improprio. Capretta lo era stata solo per qualche giorno dopo la sua nascita perché in poco tempo diventò enorme come un toro e di un toro aveva l’indole. L’unica possibilità a suo favore per essere definita capra era il colore del suo manto villoso diviso in due colori: bianco per la maggior parte sul dorso e marrone scuro verso la testa. Era veramente un bell’esemplare di capra.
Un garzone pastore del gregge dal quale proveniva, le aveva insegnato il combattimento poco dopo lo svezzamento dal latte materno. Il servo, sicuramente, si divertiva molto ad assistere ai combattimenti che la capra ingaggiava con i suoi simili, ma la questione fu totalmente diversa quando venne inserita nella campagna vicina alla nostra abitazione. La capra scambiava tutti per capre e andava coraggiosamente e pericolosamente incontro, caricando, come se fosse in un’arena. Quando vedeva bambini o animali più piccoli della sua stazza che si muovevano durante il gioco, immaginando che fossero birilli, cominciava a correre senza criterio per buttarli giù con una sola mossa.
Un giorno, mio padre, dopo un ennesimo episodio di pericolo e di paura fu costretto a tagliarle le corna.
Muntàra non si perse d’animo nemmeno con le corna a metà e, come se dovesse punire qualcuno, prese la rincorsa e si fermò, per fortuna, sulla porta principale della casa mandando in frantumi tutti i vetri.
La nonna, che aveva temuto fortemente per l’incolumità delle bambine, per quanto paralitica si era sollevata dalla sedia a sdraio e agitando il bastone, riuscì a mettere in fuga la capra che, indispettita, si allontanò per andare a pascere nella campagna vicina.
Il pericolo, per il momento era scongiurato e le bambine continuarono i loro giochi dimenticando, ma solo per quel momento, la capra nemica.
Mio padre c’insegnava a fare amicizia con quella bestia violenta e vendicativa della quale avremmo fatto volentieri a meno; l’unico modo per starle vicini ed ammansirla era la somministrazione di cibo, che comunque non le mancava mai, anche quando credeva di trovarsi in un’arena.
Abitualmente, oltre il pascolo, la capra preferiva fave secche. Io, con terrore, gliele porgevo in una piccola casseruola con manici di bachelite. Tremavo di paura e con me le mie mani e lo stesso recipiente che conteneva le fave. Speravo che la capra mangiasse in fretta per potermi liberare della sua presenza dato che non era assolutamente permesso disubbidire a mio padre. Ma lei mangiava con comodo, fino all’ultima fava, ed io con la paura in crescendo ero costretta a stare in piedi e ad assistere a tutti i movimenti della sua bocca enorme, piena di bava. Mio padre, alla mia sensazione di schifo, che era comunque inferiore alla paura, mi aveva spiegato che quella bava serviva per impastare il cibo che poi, in quanto animale ruminante, avrebbe subito ulteriori modificazioni.
Ad essere sincera tutte quelle spiegazioni non mi interessavano affatto perché ciò che predominava di fronte alla capra era sempre e soltanto la paura di essere da lei “incornata”, e questo tipo di disperazione era talvolta così forte che lasciavo cadere la casseruola delle fave e scappavo via in cerca di riparo dato che la capra mi avrebbe rincorsa e punita.
Ma mio padre non capiva.
Mi diceva che avrei dovuto essere più coraggiosa perché la capra, mia coetanea, era arrivata a casa per me, nei giorni della mia nascita e soprattutto mi avrebbe fornito, e mi aveva già fornito, il suo ottimo latte.
Ma io ero una bambina di sette anni e la presenza delle sue corna e dei suoi enormi occhi verdi non mi davano alcuna fiducia. E, anche se mi si considerava senza coraggio, preferivo che la capra non ci fosse. Infatti, quando in certi brevi periodi dell’anno veniva allontanata per l’accoppiamento, vivevo tranquilla e ogni volta speravo di non vederla più.
Questo mio desiderio stava anche per avverarsi perché il giorno stesso in cui la nonna riuscì ad allontanarla, Muntàra cadde in un’ampia fossa di fango rosso che la inghiottiva come una sabbia mobile.
L’ardita capra riuscì, dopo ore di lotta, ad uscire dalla trappola nella quale era caduta per via della sua irrequietezza e a tornare a casa, a tarda sera, grondante di fango, spaventata e stanca. Ma non arresa!
Lo zio Giovanni l’aveva cercata per tutta la giornata chiamandola per nome e agitando un recipiente con dentro delle pietre per simulare, amplificato, il richiamo del cibo ma Muntàra, non vista, nuotava nel fango e cercava di salvare la sua vita.
La fanghiglia rossa e fresca, risultato della recente estrazione dal sottosuolo, era terribilmente pericolosa soprattutto perché la bestia era rimasta immersa a lungo e ne aveva assorbito elementi che provocano delle malattie, una tra le più note e più comuni, come si diceva comunemente e riportando una traduzione letterale dal sardo era “il male del minerale”.
Muntàra si presentò a casa con passo lento e stanco, totalmente ricoperta di fango. Anche i suoi enormi occhi verdi facevano fatica a muoversi nella loro sede: sembrava una statua di cartapesta in fase di lavorazione.
Credo di aver provato per una volta e solo per un attimo un po’ di compassione per quella bestia che, conscia di quanto le era successo, era arrivata a casa e si era fermata a guardarci, immobile. Non poteva chiedere ma aspettava aiuto per il suo stato. Nessun belato, nessuna presenza della sua abituale e proverbiale prepotenza ma solo uno sguardo ed un’attesa silenziosi furono la richiesta più eloquente e più “gridata” che si potessero sentire.
Mio padre, che per quella sera non aspettava più il suo ritorno, era sul punto di uscire ma dovette cambiare programma. Fu felice di vedere la capra ma si rattristò immediatamente per quella presenza che mostrava una situazione tragica sulla quale bisognava intervenire senza lasciar passare altri attimi.
Fece quasi volare la sua giacca e corse a chiamare il suo amico Ziu Peppeddu che, dopo aver sottoposto la capra ad un accurato lavaggio, praticò un salasso terapeutico.
Muntàra venne fuori egregiamente da quel guaio e continuò a farci paura.
Ma non fu così per i capretti che aspettava.
Il “male del minerale” permise alla sua grossa stazza di portare a termine le gravidanze ma non le consentì mai di far crescere i suoi piccoli che, irrimediabilmente, venivano colpiti alle giunture ossee e non riuscivano più a reggersi in piedi. Il male, infatti, si faceva strada attraversi i piedi a contatto con la terra e, per continuità, arrivava alle prime articolazioni delle zampe.
La fine era pressoché rapida perché le bestie, non potendosi più muovere per il pascolo, morivano.
Seguirono la stessa sorte i nostri amati cani, Lupo, Laika, Paquita etc.
La malattia era tanto più aggressiva quanto più il contatto con la terra era frequente. Per questo motivo, nei cani, gli episodi di saturnismo erano continui data la libertà di vivere senza catene e con possibilità di avvicinarsi anche alle montagne di fango. Talvolta, oltre alle giunture ossee, i cani venivano colpiti da complicazioni polmonari tanto che spasmi dolorosi obbligavano mio padre al loro abbattimento.
Non era facile, nonostante fosse l’unica soluzione, liberarsi di una bestia che aveva abbracciato tante volte e che era stata attiva compagna nei giorni di caccia e custode fedele della casa.
Per questo, ricordo bene, che allo sparo subentrava il pianto.
Non fu così per il mio Bisagno.
Bisagno aveva la mia età e come Muntàra era arrivato a casa nei giorni della mia nascita. Era nato da una madre pointer pura e da un padre pointer incrociato. Si può dire che fosse puro del tutto come la madre ma, se proprio così non può essere definito, mi piace immaginare che una così brava bestia fosse perfetta anche dal punto di vista della razza.
Ma non è importante questa precisazione perché Bisagno, che aveva una sorella di nome Diva, era una “persona” così gentile e così completa che a distanza di tanti anni dalla sua morte ancora non è stato sostituito. Ancora viene nei miei sogni come creatura consolatrice.
Quando, piccolissima, stavo seduta su un tappeto e cercavo di irrobustire le gengive con un pezzo di pane, Bisagno, se si accorgeva che qualche formica poteva impadronirsi delle briciole del mio pane, emetteva un flebile abbaio per scoraggiarle. In seguito, in età scolare, mi accompagnava al bivio della strada senza mai attraversarla e, quando al ritorno mi vedeva spuntare dall’ultima curva, andava ad aspettarmi nel punto in cui mi aveva lasciata. Il mio affetto era ricambiato e tutti i giorni rinunciavo per lui ad un pezzetto di carne del mio pranzo. La domenica gli riservavo un pezzetto del gateaux di mandorle che preparava mia madre.
Fu proprio mentre mangiava un pezzo di gateaux che scoprii, nel palato, una macchia scura testimone che la razza era quasi pura.
Il dolore per lui si fa struggente e mi commuove ancora fortemente anche se sono passati tanti anni da quando se n’è andato.
La morte avvenuta a dodici anni, mi gettò nello sconforto e cominciai a pregare forte con la certezza che Bisagno sarebbe tornato.
La sera pregavo fino a tardi e, pur sapendo che né le persone né tanto meno i cani ritornano, la mattina presto, all’alba, scendevo di corsa al piano terreno della casa; senza fiato aprivo la porta e mi spingevo fino all’arco esterno della tenuta. “Da lì”, dicevo a me stessa, “da lì potrò vedere bene come Bisagno correrà da me”.
Ed ero convinta che per me si sarebbe verificato il miracolo. Ancora non sapevo che ciò che si ama più forte è proprio ciò che si perde prima.
[continua]


